Certo non per sciogliere l’ennesimo, retorico peana.
A me interessa, del ’68 e di quanto da esso è conseguito sino a giungere a lambire la mia personale vicenda umana, riflettere sul volto ‘sloganistico’ della cosa.
“La vita è la realizzazione del sogno della giovinezza”: con questa frase, vero e proprio slogan dei ‘migliori anni’, io, e parecchi altri, ci siamo incamminati verso la vita adulta.
E ci credevamo fortunati.
Molto più fortunati dei nostri genitori, così antiquati e legati a convenzioni demodées, una su tutte: quella di credere all’esistenza di un bene e di un male, veri, oggettivi, identificabili con l’uso sano di ragione.
E ci credevamo padroni del mondo.
E, in realtà, eravamo solo gli epigoni di una mistificazione collettiva dai risvolti - almeno per taluni - disastrosi.
La fine dell’illusione - per me - ha cominciato ad intravedersi quando scoprii un altro slogan.
Diceva: “Sognate, e la realtà sarà più grande dei sogni più audaci”.
Proveniva dallo stesso mondo apparentemente identicamente cristiano e cattolico.
Ma uno - il primo - era già qualcosa d’altro, probabilmente, senza nemmeno immaginarselo.
La seconda frase mi ha colpito per l’indubbia onestà di fondo che l’altra ignora: anziché esaltare il sogno - per quanto entusiasmante e vitale sia per ognuno di noi sognare - riinvia chiaro e netto alla realtà.
Tiene ferma come vera ricchezza e meta da non perdere, esattamente la realtà.
Che altro non è che quella cosa che da ogni lato ci circonda e che sempre - volenti o nolenti - è la misura di ogni sogno, velleità, azione.
Certo, in tempi di ‘utopia al potere’ (classico enunciato sessantottino, e, appunto, classicissimo esempio di come componendo assieme delle parole, si possa anche dire niente) risulta discretamente urtante il rinvio alla realtà, questa cosa dura, estranea, oggettiva e così poco pronta alla blandizie dei nostri ghirigori mentali.
Il primo slogan, ‘saggiamente’ promette invece che sarai TU, coi tuoi sogni (leggi: pretese), a vincerla sulla realtà.
In questo apparentemente banale scambio di termini si coglie quanto tutta un’epoca abbia campato sulla lusinga.
E - conseguentemente - sul superomismo.
Rivedendo, nostro malgrado, parecchi svarioni poi fatti (tipo condanne a parecchi anni di galera, accuse di gravi truffe e atti corruttivi, nonché tradimenti - ma non vorremmo sembrare troppo sentimentali - di fiducia) dagli aedi di tale slogan, nonché registrando gli arroccamenti insensati di quanti più a gran voce lo sostenevano, è oggi impietoso, ma necessario constatare che - se di qualche sogno la realtà sarebbe dovuta essere la realizzazione - il bilancio vira prepotentemente verso il basso.
Non era, e non può essere, ragionevole e nemmeno molto cristiano percepire la realtà come ottuso ambito di resistenza alla libertà del soggetto, alle sue aspirazioni e desideri.
Sarebbe così, solo accettando che il mondo, la realtà tutta siano solo frutto del caso e della più pura gratuità senza senso.
Arriva sempre una mattina in cui ci si sveglia, ed ecco ci si rende conto che il discorso sui ‘sogni’, usato come esca per attirare verso un futuro in cui finalmente la realtà - per quello che è - si adeguerà alle nostre voglie, diffonde il retrogusto della presa per i fondelli.
Meglio, molto meglio (e senz’altro più degnamente cristiano) ritenere che tutto il bello che c’è in me, nei miei sogni, sarà potenziato dal reale attorno a me, a patto di starci innanzi in maniera adeguatamente umana.
Cioè: con Fides et Ratio.
E’ inquietante rileggere lo slogan sulla ‘vita come realizzazione dei sogni della giovinezza’ alla luce del refrain hippy degli anni ’60:
”Fai le tue cose, ovunque devi farle e ogni volta che vuoi.
Fai sballare qualsiasi persona normale con cui vieni in contatto.
Fagli scoprire se non la droga, almeno la bellezza (!), l’amore(!), l’onestà(!) e il divertimento”.
L’occhiolino strizzato da determinati movimenti, al ‘sogno’ (spesso contrabbandato come ‘destino’ e/o ‘tensione all’ideale’) altro non è stato che l’azzeramento poco saggio di ogni distinzione tra utopia e ideale.
Stile ampiamente diffuso, un po’ a tutti i livelli, nella seconda metà del secolo scorso, come T.Molnar ci narra nel suo “L’utopia, eresia perenne”.
Ma chi se ne è reso conto?
Il ’68 non è stata una forma, sia pure singolare, di ‘protagonismo giovanile’; non un movimento di lotta per la giustizia sociale; non un impegno collettivo per migliorare la società in vista dei suoi fini naturali.
Il ’68 propone e segue, in un contesto ‘collettivistico’ (o ‘comunitario’, se ci manteniamo in area cattolica) l’illusione sostanziale di un anarchismo qualunque.
Se non come forma politica, certamente come forma mentale.
Con evidenti ricadute etiche, ovviamente.
Il ’68 si riduce a fare del collettivismo (o della ‘comunità’) la condicio sine qua non dell’anarchia, quella categoria ‘culturale’ in cui il ‘dovere’ viene identificato come limite puro e semplice alla propria libertà.
Se non lo avessi sentito con le mie orecchie si faticherebbe a credere che dal mondo ’cattolico’, e da personaggi in esso anche fortemente ‘referenziati’, potessero formularsi assiomi del tipo: ”Non me ne frega niente, se la verità è un’ altra.
A me va di fare così.
E faccio così”.
Il famoso suicidio della Rivoluzione di delnociana memoria, in fondo, altro non è che questo: un cambiamento non per introdurre una novità vera, oggettivamente ‘altra’, ma solo come fine a se stesso.
Una libertà invocata per realizzare un unico progetto: quello della propria impulsività.
Per soddisfare l’attimo.
Usando termini di Julia Kristeva mi permetto di dire che ‘si capisce come nello sconvolgimento della psiche contemporanea, che costituisce per noi un buco nero impossibile da simbolizzare’, il ricorso allo slogan rappresenta il successo (l’unico, probabilmente ) ‘nel buco nero dell’autismo che ci contraddistingue’.
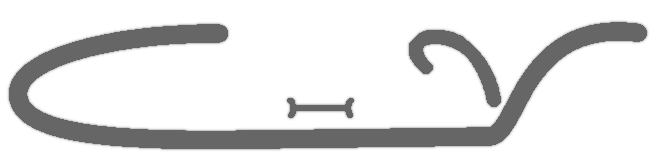
"Ed ecco la mia vita
Giunta sino all’orlo
Come un vaso d’alabastro
Infrango innanzi a Te"
Boris Pasternák
©Carla Vites - powered by M.to.M