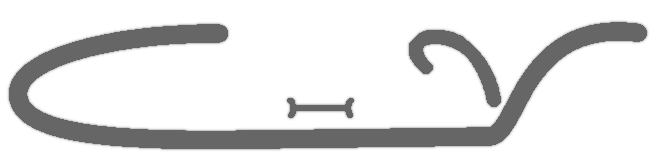Una madre, una sentenza ed un pezzo di scotch
Passato qualche giorno dal verdetto, l’immagine di quella donna anziana, la madre, in un cimitero di provincia, china sulla tomba della figlia uccisa a 20 anni trent’un anni fa, intenta ad incollare con lo scotch una sentenza di Tribunale sulla lapide, non passa.
Non mi passa.
E capisco una volta di più quanto dolente sia essere madre. Sempre.
Ma in modo particolare oggi.
Una sentenza, dopo trent’un anni: desiderio estremo finalmente corrisposto di non lasciare il corpo della sua bambina portato nel suo seno nove intensi mesi e poi nel suo cuore, con la sua cura e dedizione, per quei venti lunghi/rapidissimi anni, sciogliersi così, nelle nebbie del nulla, come in un atavico Hotel Lux qualunque si sarebbe scelto di fare.
L’Hotel Lux che -non essendo più sulla Tverskaja, a Mosca- è oggi diffuso ovunque attorno a noi e pretenderebbe che tutto fosse uguale a tutto, cioè a zero.
Ma una mamma non può accettarlo.
Sarebbe come dire che il figlio o la figlia le siano stati recapitati a titolo di pacco anonimo e come un pacco lei lo abbia posato su una mensola per poi farselo più tardi ritirare da sconosciuti senza volto e, soprattutto, senza un perché.
Già, infatti una mamma che sia tale, è la paladina del perché…
Davanti alla brutale sparizione senza motivo della luce dei suoi occhi, il figlio, o la figlia come in questo caso, esige un perché.
Infatti LA MADRE, ‘il femminile’ in mezzo a noi, è la forma della ragionevolezza vera.
Ma non quella dell’ideologia qualunquista dell’utero è mio, bensì quella che ammette il limite, la ‘passività’ perché esprime in essa la condizione che pur non voluta, c’è, esiste è in ognuno di noi e davanti a cui tutti dobbiamo rendere conto.
Il limite è oggi notoriamente la parola più aborrita.
E con l’odio ad essa, la parola dialogo è la più abusata.
E’ lei, una mamma a ricordarci che non è umanamente possibile cedere alle nebbiosità irragionevole del tutto è uguale a tutto, e, per amore della figlia, ha dimostrato a tutti che senza una ragione non si vive.
Lei, questa madre, ha lottato trent’anni perché, se a Lidia doveva dire addio, questo addio avesse almeno una ragione.
Che dire poi se la ragione scoperta a costo di dolori, indagini, notti in bianco a piangere e ricorsi processuali, se questa ‘ragione’ è senza ragione?
Dovremmo onestamente dire che Lidia ha pagato il prezzo di un mondo malato molto più vasto del suo giro di amici ed amiche, dei suoi compagni di Università, del suo desiderio di amare e di essere riamata.
La sua assurda morte è stata la rappresentazione dell’assurdità di un’epoca intera: l’epoca della distruzione del padre.
Anche se a pagarne le conseguenze sono paradossalmente le donne, cioè le madri…
Un mondo che nega al figlio maschio di identificarsi con figure ormai destinate al pubblico ludibrio come i padri, perché al ludibrio va gettata ogni forma di cosiddetta ‘autorità’, mentre senza autorità non si cresce, è esattamente un mondo che non consente di ammirare colui che nella triade edipica garantisce la lotta, la sopravvivenza in un mondo ostile .
Resta solo la madre, bene rifugio e sfruttato come eternamente consolatorio.
Bene che non proietta al di là del cerchio magico del proprio narcisismo, ma ne consacra eternamente le pretese.
Il padre che manca, sminuito, ridicolizzato , sovente , lui per primo, aspira a rimpicciolirsi e scomparire per non subire l’impaccio di dover essere il ‘cattivo’ che dà le regole.
Il Padre, questo padre, rimane oggetto di un disperato desiderio che non si sa come lasciar andar via.
Lo si odia o lo si compatisce, il proprio padre, ma, insomma, non si sa come farne a meno.
E allora, in alcuni casi, nemmeno troppo rari purtroppo, la paranoia si incarica di ‘sbrigare’ la bisogna.
Cosa diffusissima, questa di ‘cedere’ alla paranoia, e che significa esattamente ‘incollarsi’ su un oggetto da cui però non ci si può distaccare.
Con lei, a braccetto, ecco il delirio: tentativo di conservare -nella trasformazione- la rappresentazione, cioè il padre, il desiderio infinito di lui, respinta.
Questo meccanismo vale per moltissime situazioni ma il caso di una ragazza che viene amata sul sedile della sua auto e poi, immediatamente dopo, accoltellata fa intuire in modo tragico come il ‘femminile’ sia investito di colpe che la paranoia non riesce ad accollare al proprio vero oggetto.
Quell’oggetto che nell’omosessualità, prima messa in luce e poi in ’maniera politicamente corretta’ si è preteso di ignorare, durante la sequenza processuale, viene ricercato proprio nell’ “òmoios”.
Un oggetto “òmoios” serve a fissare libidicamente su di un punto, il desiderio di un padre vissuto sadomasochisticamente.
Non può questo personaggio provare ammirazione per il padre e contemporaneamente vivere una fiduciosa e amorevole dipendenza (dipendere non sia mai…roba da donnette!) da lui.
C’è quasi sempre un’incapacità propria, come di chi svolge il ruolo di ‘educatore’ attorno al personaggio in questione, di ridimensionare la megalomania che in loro è sempre presente (ancora dopo anni, al processo, l’insegnante interrogato magnificherà l’intelligenza, le doti e la personalità leader dell’imputato poi dichiarato colpevole dalla Corte. “Leader” che dai 17 anni in su aveva avuto bisogno del ‘buco’ per sopravvivere).
Per questi personaggi assediati dalla paranoia, la donna diventa necessaria per allontanare col proprio successo su di lei il dubbio della propria passività di fronte alla vita e alle proprie pulsioni interne mal represse.
Pulsioni, anzi, talora cullate, blandite, assecondate (vedi le lettere d’amore che l’imputato di questo processo riceveva da uomini).
La donna diventa però anche la conferma della disgregazione del proprio mondo interno, quella da cui l’ ‘òmoios’ doveva salvarci.
Lei è un nemico.
Lei è la personificazione del male assoluto.
Lei è l’oggetto respinto nella sua persecutorietà (i periti psichiatrici parleranno di ‘reiezione della donna’ da parte dell’imputato).
Oggetto reietto però, l’istante dopo, sentito disperatamente iperpresente nel proprio delirio: lei diviene così la musa ispiratrice di un poema sulla sua stessa morte…
O sulla epica lotta per sopravvivere a chi in realtà voleva -forse- solo amarlo?
Rileggendo un lavoro di Freud interessantissimo sotto questo profilo, scritto nel ’10 riguardo al caso Schreber (ovviamente oggi passato sotto silenzio per essere politicamente corretti) è drammaticamente decifrabile come Lidia sia finita nel tritacarne di una ‘civiltà’ che in tutto e per tutto riflette ormai solo tempi di cui si sognava fosse ormai sparito il ricordo: l’età della pietra.
In un commento al ‘Caso del dottor Schreber’ esaminato da Freud leggiamo:
“Se l’omosessualità inconscia è rigettata, non serve alla sublimazione (cosa che Freud considera fondamentalmente positiva come ben si sa, nota mia).
Si presta invece ad essere solo scaricata, aumentando il tasso di conflittualità agita, nonché il senso di persecuzione e di esclusione.
Così, come l’adattamento passivo.
Determinando infine un funzionamento simile a quello delle società primitive, dove la questione del potere si esplica nei rapporti di forza, i quali finiscono per scalzare le ragioni profonde che legano tra loro i componenti di un determinato gruppo (come possono esserlo le ragioni scientifiche). Questo fenomeno che ai giorni nostri è eclatante, lo vediamo nel mondo universitario, lavorativo in genere , e non può essere escluso per gruppi e associazioni.
Vediamo come alla base vi siano sentimenti più o meno agiti su “l’essere il preferito o l’escluso” dal padre, il formarsi di gruppi secondo logiche di potere o ideologiche, aventi in comune aspetti legati a una non elaborazione degli aspetti omosessuali inconsci, all’assenza dell’elemento “femminile”.
L’elemento femminile, questo tratto così sorprendente della vita psichica umana, è la metafora stessa del limite: limite all’analizzabilità, limite della capacità di conoscenza di noi stessi (Semi, 2006), limite delle nostre teorie, limite della natura umana. Questo limite è dunque il “femminile”, una sorta di “ombelico del sogno”, punto di indecidibilità, di insaturo, di attesa, di parola sospesa.
Parlare di omosessualità, anziché considerarla un fatto ‘privato’ come si è preteso nel processo di Lidia, allora, potrebbe essere utile -a mio sommesso avviso- dal punto di vista giudiziario.
Ma potrebbe essere utile ancora di più, forse, anziché limitarsi a compatire o a accusare un colpevole, accorgersi che lui l’accusato, non è solo, ma che il banco degli imputati è sovraffolato.
Trent’anni per chiarire una cosa che da subito, da chi di dovere doveva essere stigmatizzata, è stata invece immediatamente spacciata come “aggressione a Cosa Loro”, al gruppo.